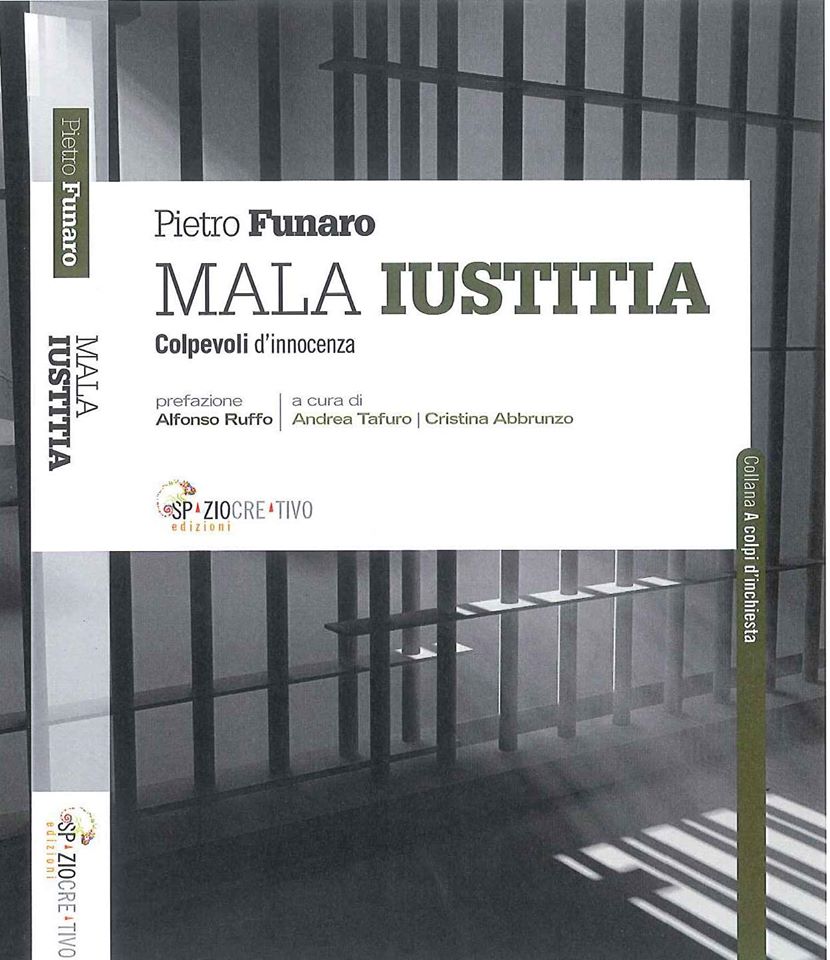La malagiustizia, anzi: la Mala Iustitia, esiste, c’è poco da fare. E con questa bisogna fare i conti quando si scivola nelle sabbie mobili di procedimenti giudiziari estenuanti spesso accompagnati dal macabro corollario di detenzioni rigide e preventive. Costretti in carcere per reati che non si è mai commessi.
La malagiustizia esiste, occorre rassegnarsi. Con buona pace dei tanti innocenti che finiscono col pagarne le conseguenze subendo danni incalcolabili (e qualche volte irreversibili) per la loro salute psico-fisica. Tuttavia c’è anche la buona giustizia, l’unica che veramente dovrebbe contare nelle aule dei tribunali. E che, con un gioco di parole, se applicata correttamente, contribuisce a spazzare via gli errori provocati dalla “malagiustizia” emendando ciò che giusto non è.
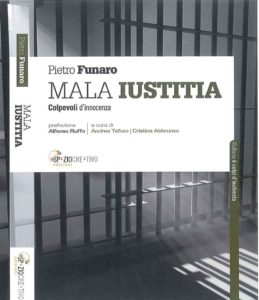
Di questo parla nel suo ultimo libro “Mala Iustitia, colpevoli d’innocenza”, per i tipi di Spazio Creativo Edizioni (nuovo titolo della collana “A colpi d’inchiesta”), il giornalista partenopeo Pietro Funaro. Quasi una sorta di autobiografia, la sua, che si snoda attraverso un estenuante e a volte commovente viaggio nel passato, alla riscoperta della propria drammatica odissea giudiziaria.
Pagine e pagine di vita vissuta, scritte col piglio del cronista d’assalto. Tremendamente semplici da leggere nella loro cruda essenza. Capitoli da scorrere tutti d’un fiato ed in cui balzano agli occhi anomalie e incongruenze di un certo tipo di magistratura forse un po’ troppo incline alle imputazioni facili, ispirate allo speciale, quanto inflazionato, reato del “concorso esterno in associazione mafiosa”.
Un reato che, per dirla con le parole del Procuratore Generale della Corte di Cassazione Francesco Iacoviello “è diventato un reato autonomo a cui non crede più nessuno”. Ma che Funaro analizza e passa in rassegna fin nei minimi dettagli nella parte iniziale del volume.
Un “reato non reato”, perché non esattamente contemplato nel codice penale, ma scaturito dall’accorpamento tra gli articoli 110 e 416-bis per fornire ai giudici un nuovo strumento giuridico in grado di reprimere le eventuali condotte di fiancheggiamento, collusione e contiguità con i clan della malavita organizzata. Ma che talvolta, utilizzato come capo d’imputazione “improprio”, ha finito per dar vita a una specie di “virus giudiziario” letale – quello di cui parla Funaro – che, diffuso nelle aule delle Procure, ha contribuito a rovinare per sempre la reputazione di uomini politici onesti e innocenti. Indagati, costretti alla sbarra, sottoposti alla gogna mediatica ed a quella della prigione pur non avendo mai commesso il fatidico “fatto”.
Un virus che solo per caso ha risparmiato l’autore stesso del libro, giunto alle soglie dello sfinimento fisico dopo aver urlato invano la propria innocenza ed essersi sorbito quasi duecento giorni di detenzione, prima nella casa circondariale di Poggioreale, poi nel carcere di Secondigliano. Arrestato per ben tre volte di seguito, l’ultima “per un fatto etico” come si sentì rispondere nel momento in cui gli venivano strette, per l’ennesima volta, le manette ai polsi. E poi scagionato da ogni colpa, rimesso in libertà. Riconsegnato alla vita da un altro tribunale, dopo anni e anni di patimenti e sofferenze, perché semplicemente innocente.
“Il ricordo non si può cancellare. Quello resta per sempre, come il dolore per le vessazioni subite” spiega Pietro Funaro a distanza di quindici anni dall’inizio del suo tremendo calvario. Ed è questo che, più di tutto, sembra animare la penna impugnata dal giornalista. Quasi un rito di purificazione quello scelto per mettere benzina nel motore. Uno sfogo, la scrittura, affidato ad un pezzo di carta bianca su cui finisce per scaricarsi il peso di tante angosce patite, giorno dopo giorno, nelle fredde e inospitali pareti di una cella. Lì, fianco a fianco con camorristi e criminali comuni. Un meccanismo con il quale trasmettere agli altri la propria “verità” rendendola accessibile a tutti, condividendola con i lettori. Un modo, quello individuato da Funaro nel suo libro-dossier, con il quale ricominciare a vivere.
“La Giustizia è una cosa troppo seria e non dovrebbe mai somigliare a una partita a dadi” scrive l’editore-direttore de “Il Denaro” Alfonso Ruffo nella prefazione del testo. “La ricerca della verità e il compito delicato di espellere dalla società i soggetti che non ne rispettano i fondamenti, sono obiettivi sensibili e irrinunciabili la cui centralità non può essere messa in discussione per la leggerezza, il capriccio o la voglia di protagonismo di alcuni” rincara la dose Ruffo.
Ed è contro quel capriccio che alza la voce l’autore. Contro quella “partita a dadi” che minaccia di attentare all’integrità della Giustizia. Con un distinguo, però, che merita di essere sottolineato. Soprattutto in questa fase. Attenzione, infatti, a parlare di “malagiustizia”. Non è il caso, infatti, di fare di tutta l’erba un fascio. Perché quello di Funaro non è un libro contro la magistratura tout court. Né un modo, il suo, di assolvere i politici dalle accuse di corruzione. Niente affatto. Nel volume edito da Spazio Creativo, viene, all’opposto, intonato un inno alla vera giustizia. Alla sola unica giustizia che conta. E si punta il dito contro certe pratiche di malaffare di cui non sono immuni gli amministratori della cosa pubblica. Ma, così come si attaccano i “politici che rubano”, così come si riconosce il marcio della politica, allo stesso tempo vengono manifestate forti critiche nei confronti di certe “toghe di parte”. E questo viene ribadito sciorinando dati e cifre, con l’ausilio di pareri di studiosi della dottrina giuridica ed estratti di articoli e servizi di giornale.
Ampio spazio, inoltre, viene dato nella parte centrale di Mala Iustitia alle vicende giudiziarie di alcuni protagonisti della vita politica italiana del periodo compreso tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90, finiti nel mirino dei giudici, processati sui giornali, quindi sottoposti alla gogna del carcere. E poi, successivamente assolti, quando magari era già troppo tardi per alcuni di loro.
È il caso di Antonio Gava, Carmelo Conte, Calogero Mannino, Carmine Mensorio e Felice Di Giovanni, di cui, grazie al racconto di Funaro, rivive il drammatico travaglio. Con epiloghi tremendamente diversi, di personaggio in personaggio. E’ questo, ad esempio, il caso dell’ex deputato della Dc Mensorio, morto suicida dopo aver urlato al mondo la propria innocenza, in una lettera indirizzata al critico d’arte Vittorio Sgarbi e dell’onesto funzionario di Regione Felice Di Giovanni, stroncato, successivamente, da un male incurabile, ma non senza prima essersi preso la soddisfazione di vedersi scagionare da ogni accusa.
Lo scopo di Pietro Funaro, con questo suo Mala Iustitia, diventa lampante nella parte finale del libro. Quasi una sorta di manifesto-appello, il suo. Che merita di essere letto con particolare attenzione, fino in fondo: “…oggetto di questo libro-indagine, è la disfunzione dell’amministrazione della Giustizia che colpisce la comunità e che provoca sfiducia verso le istituzioni e genera un vero e proprio black out in quello che dovrebbe essere un sano rapporto Stato-cittadini. Quindi, con fermezza, possiamo dire che la malagiustizia è la causa dell’ingiustizia”.